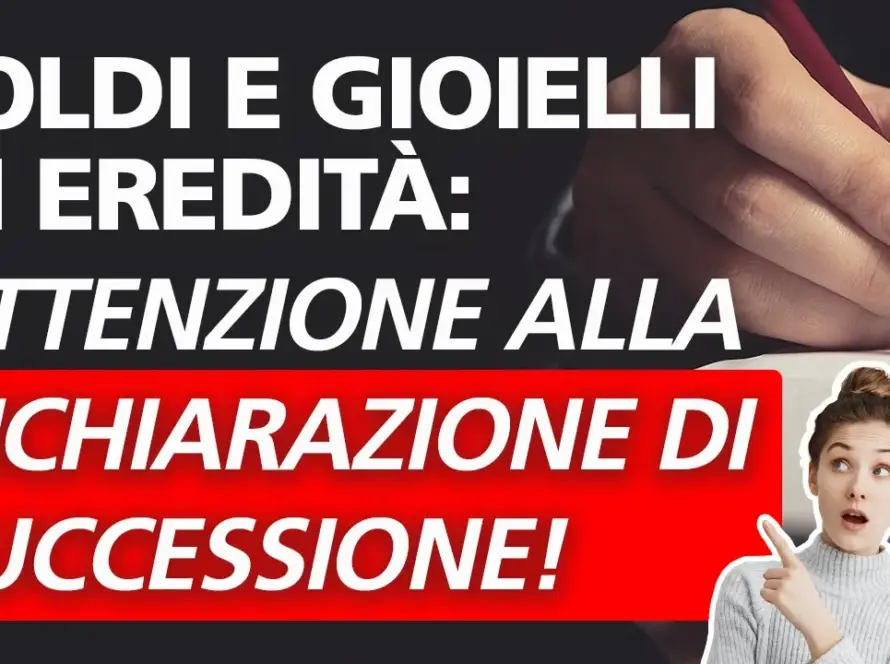Rispondiamo a una domanda concreta: quando nell’eredità c’è una casa che non si può dividere senza rovinarla o creare squilibri, chi la prende? La regola è nell’articolo 720 del Codice Civile; la traduciamo in italiano semplice con esempi e indicazioni pratiche.
“Non comodamente divisibile” vuol dire che, pur potendo magari dividere sulla carta, farlo sarebbe inutile o dannoso: il frazionamento costerebbe troppo, toglierebbe funzionalità, o produrrebbe lotti squilibrati. In questi casi, la legge propone una via più lineare.
La soluzione è l’assegnazione preferenziale: l’immobile viene attribuito per intero a un coerede, con un conguaglio in denaro agli altri. Se più coeredi la chiedono insieme, possono riceverla in comproprietà, sempre con i conguagli necessari. La vendita all’asta è il piano B, non il piano A.
C’è una parola che pesa: “preferibilmente”. Non vuol dire “sempre e comunque”. Vuol dire che il giudice sceglie la strada migliore nel caso concreto, e deve spiegare perché. La Cassazione ha ribadito proprio questo: il giudice ha un margine di valutazione, non un automatismo.
Per capirci meglio, pensiamo a due fratelli con quote diverse. Se il maggior quotista chiede l’assegnazione, in genere ha una corsia preferenziale. Ma non è un diritto assoluto: conta anche la sostenibilità dei conguagli, l’interesse degli altri, la destinazione dell’immobile e la soluzione più equa nel complesso.
Come si decide se la casa è davvero “non comodamente divisibile”? Si guardano i numeri e il buon senso: se per spaccarla in due servono lavori costosi, oppure i conguagli diventano talmente alti da svuotare il senso della divisione, allora la divisione in natura non è conveniente. In simili casi l’assegnazione è la via più logica.
Dal punto di vista del procedimento, la vendita si usa quando nessuno chiede l’assegnazione o quando l’assegnazione non è praticabile. Se almeno un coerede la chiede e i conti stanno in piedi, la vendita diventa una soluzione residuale.
Un altro tassello: il giudice può attribuire l’immobile anche a chi ha una quota minore, se la scelta regge sul piano dell’equità e dei numeri. Per questo è importante presentare proposte chiare e sostenibili, con stime serie e un piano di conguagli credibile.
Proviamo a visualizzare una scena tipica. Casa del valore di 300; tre eredi con quote 50–30–20. Se il fratello al 50% chiede l’assegnazione e si impegna a pagare i conguagli, è spesso la soluzione più ordinata. Se invece i due minori chiedono insieme di tenerla in comproprietà e i conguagli sono sostenibili, il giudice può preferire quella strada.
E se uno dei coeredi vive già lì? È un elemento che può pesare, ma non dà un titolo automatico. Conta l’interesse di tutti e la fattibilità economica. Se l’uso esclusivo ha creato squilibri, si sistemano dentro la divisione con conguagli o indennità.
Una nota pratica sui conguagli: non sono una “multa”, sono il modo per pagare a chi esce la parte di valore che non riceve in beni. Conviene pianificarli: tempi, modalità, garanzie. A volte si concorda un pagamento scaglionato o garantito da ipoteca, per evitare tensioni.
C’è anche un riflesso fiscale da non dimenticare: se le attribuzioni superano troppo le quote, una parte può essere letta dal Fisco come “trasferimento” e scontare l’imposta proporzionale. Meglio costruire porzioni equilibrate per restare nel regime più leggero.
Quali documenti portare? Una perizia attendibile sul valore dell’immobile, i preventivi delle opere divise, le proposte di conguaglio con piani di pagamento, e – se l’immobile è abitato – i dati utili per valutare eventuali compensazioni per l’uso.
Qual è l’errore più comune? Arrivare in tribunale senza una richiesta chiara di assegnazione oppure con un progetto che regge solo sulla carta. Senza richieste, il giudice può scegliere la vendita; con richieste fragili, i tempi si allungano e i costi crescono.
Se guardiamo alla sostanza, l’articolo 720 è uno strumento per evitare che una casa diventi un campo di battaglia: meno muri tirati su a caso, più soluzioni sostenibili. Decide il giudice, ma chi prepara bene i numeri guida la decisione.
Chiudiamo con tre idee chiave: la divisione in natura è la regola, ma quando non ha senso si passa all’assegnazione; la vendita arriva solo se l’assegnazione non è possibile o nessuno la chiede; il criterio del “maggior quotista” orienta, non comanda. Il resto lo fanno le carte e il buon senso.
Un dovuto ringraziamento va fatto all’avvocato Francesco Frigieri, nostro amico e collaboratore, senza il quale la realizzazione di questo video non sarebbe stata possibile.