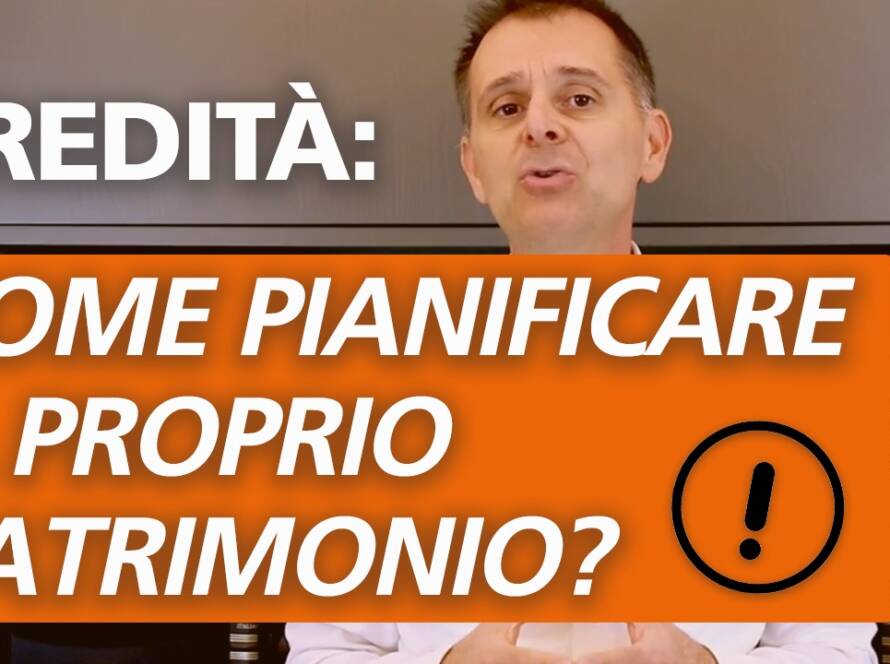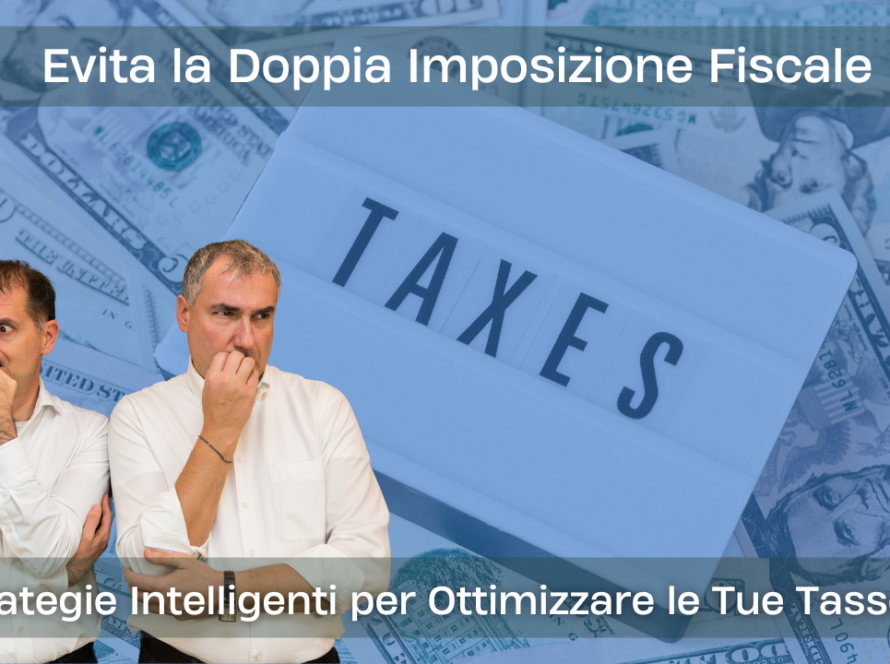Inauguriamo il primo di tre episodi dedicati a un tema che ormai incontriamo ogni giorno: geopolitica e mercati. A prima vista può sembrare distante dal portafoglio di un risparmiatore: i rischi geopolitici sono imprevedibili e spesso non misurabili come una curva dei tassi. Eppure quei cambiamenti disegnano lo scenario in cui imprese e investitori si muovono: rotte commerciali, energia, sanzioni, sicurezza delle forniture. Questa è la prima di tre puntate.
Partiamo dal vocabolario. Geopolitica: parola coniata dallo svedese Rudolf Kjellén per indicare i problemi politici che nascono da fatti territoriali—quando consideriamo lo Stato come un organismo che nasce, cresce e può decadere e che, come gli esseri viventi, cerca uno spazio vitale. “Spazio vitale” significa, in modo semplice, lo spazio necessario per sopravvivere e prosperare; il termine è stato poi stravolto nel Novecento per giustificare espansioni aggressive, e va quindi maneggiato con cura. Tra le due guerre la scuola tedesca guidata da Karl Haushofer portò la geopolitica verso un determinismo rigido—cioè l’idea pericolosa che la geografia determini in modo inevitabile la politica—finendo per legittimare l’espansionismo e il razzismo del nazismo. Da qui il lungo discredito della disciplina nel dopoguerra.
Dagli anni Settanta la parola torna in campo con un taglio più pragmatico: studiare le relazioni di potere per il controllo dello spazio e delle risorse. Qui spunta un dubbio: la geopolitica è geografia politica con un altro nome? Non proprio. Molti studiosi distinguono: la geografia politica descrive e spiega come sono organizzati i territori e le istituzioni; la geopolitica applica quella conoscenza a conflitti, strategie e obiettivi di attori che competono su uno spazio (Stati, alleanze, talvolta attori non statali). In breve: la prima è più fotografia, la seconda è mappa di gioco con i pezzi che si muovono.
Definiamo bene anche geografia politica. È la branca della geografia che studia e rappresenta il territorio e la distribuzione dei fenomeni sociali, politici, economici: confini, città, flussi, istituzioni. “Studiare e rappresentare” significa misurare e descrivere: dove stanno le cose, come si collegano, che regole le governano. È la base cartografica e interpretativa su cui chi fa geopolitica costruisce le proprie analisi. Se immaginate un cantiere, la geografia politica è il rilievo del terreno; la geopolitica è il progetto su quel terreno.
Riprendiamo il punto sul discredito storico—non per ripeterci, ma per capire perché serve metodo. Quando la geopolitica è piegata a determinismo (“la geografia decide tutto”), diventa ideologia. Il nostro approccio, invece, è analitico: si osservano attori, interessi e vincoli, si confrontano mappe e dati, si ammette l’incertezza. Così la geopolitica torna ad essere uno strumento utile a chi investe: non profezie, ma contesto leggibile.
E qui arriviamo al metodo contemporaneo: come ricorda spesso Lucio Caracciolo, la geopolitica analizza conflitti di potere in spazi determinati. Non è una scienza esatta: non ha leggi universali né formule predittive infallibili. È uno studio di casi che incrocia storia, geografia, antropologia, economia. E include anche scelte amministrative apparentemente tecniche—come il disegno di un collegio elettorale o la giurisdizione di un tribunale—che spostano i rapporti di forza.
Passiamo agli effetti di mercato. Il rischio geopolitico non si prezza come un tasso di interesse, ma agisce tramite tre canali che possiamo osservare: energia (costo e disponibilità), commercio (rotte, porti, sanzioni) e fiducia (investimenti, valute). Una sanzione—spieghiamolo semplice—è un divieto o limite imposto per condizionare il comportamento di un altro attore: può bloccare pagamenti, forniture, tecnologie. Le contro-sanzioni rispondono colpendo settori inattesi: agrifood, logistica, componentistica.
Attenzione anche al “rischio moda”: usare la parola geopolitica senza metodo crea rumore. L’analisi seria mette a confronto le rappresentazioni dei soggetti in competizione sullo stesso territorio: ognuno ha la propria narrazione del passato e un progetto per il futuro, entrambi “razionali” dal proprio punto di vista. Il metodo è dinamico: segue i dossier nel tempo e nello spazio, sapendo che ogni mappa è parziale e ogni confine una frizione potenziale.
Perché nella guerra fredda la geopolitica è passata in secondo piano? Perché lo scontro ideologico—liberal-democrazia vs comunismo, mercato vs pianificazione—ha tenuto nascoste molte faglie territoriali sotto etichette morali. Quando la cortina si è assottigliata—prima con la frattura tra Cina e URSS, poi con la fine del blocco sovietico—quei conflitti geografici sono riemersi. Capirne i vettori aiuta a leggere i movimenti di prezzi e capitali.
Guardiamo l’Europa sulla carta. Oggi contiamo oltre cinquanta Stati; nel 1914 dominavano pochi imperi; nel 1949 una cortina di ferro tagliava il continente. Più Stati significa più frontiere, regole e burocrazie: cresce il numero dei punti di attrito dove merci e pagamenti possono bloccarsi. E c’è uno strato informale: Stati-mafia o mafie-Stato—sistemi criminali che controllano pezzi di territorio e funzioni pubbliche—capaci di condizionare porti, dogane e appalti.
“Oggi la geopolitica è carica di storia.” Gli attori selezionano miti e memorie per legittimare il presente: è la retroversione del presente—si cerca nel passato ciò che giustifica la mossa di oggi. Per l’investitore, riconoscere questa operazione è un vaccino: dietro la retorica contano rotte, contratti, infrastrutture, perché è lì che passano costi e margini.
Inseriamo tre chiavi tecniche, spiegate subito in semplice. Chokepoint = collo di bottiglia: uno stretto o passaggio obbligato da cui transita una quota cruciale di energia, container, grano. Se si blocca, le rotte si allungano, i noli (costi di trasporto) salgono, i tempi si dilatano: prezzi più alti, margini compressi. Prima di guardare i listini, chiediamoci: dove sono i chokepoint del settore che seguo?
Seconda chiave: embargo = divieto (totale o parziale) di commerciare con un Paese o su un bene. Effetti tipici: offerta più scarsa, riallocazione delle filiere, spinta a investire in infrastrutture alternative (rigassificatori, nuovi oleodotti), ricerca di vie legali di sostituzione. Sul portafoglio vuol dire volatilità nel breve e nuovi equilibri nel medio.
Terza chiave: sanzioni finanziarie. Sono i tubi dei pagamenti che si chiudono: limitazioni a circuiti di messaggistica bancaria, congelamento di asset, divieti di finanziamento. Un contratto perfetto sulla carta diventa ineseguibile se la banca non può trasferire fondi. Risultato: liquidità tesa, valute che oscillano, premio per il rischio che sale.
Parliamo di energia. La geografia energetica decide costi e dipendenze. Gasdotti e oleodotti sono rigidi: se un tubo si chiude, servono anni per sostituirlo. Il GNL (gas naturale liquefatto) offre flessibilità—si compra via mare dove conviene—ma richiede rigassificatori e navi metaniere. Cambiare mix (più GNL, meno gasdotto) sposta prezzi, margini industriali e perfino la politica estera dei Paesi importatori.
E il commercio? Le catene globali del valore sono una staffetta: progettazione in un Paese, produzione in un altro, assemblaggio in un terzo, vendita in un quarto. Se una dogana si chiude o una norma cambia, la staffetta inciampa. Per ridurre il rischio, molte aziende adottano nearshoring (avvicinare la produzione) o friend-shoring (spostarla in Paesi politicamente affidabili). Meno geopolitica, spesso più costo: è il compromesso da valutare.
Torniamo all’Europa: la moltiplicazione delle frontiere ha un costo fisso di complessità; lo strato informale di mafie-Stato aggiunge incertezza “sotto traccia”. Per l’investitore significa che, oltre agli indicatori macro, serve una mappa degli attriti: dove possono nascere bottleneck logistici? Quale porto è vulnerabile a scioperi o infiltrazioni? Quali dogane hanno procedure più lente? Questa cartografia dell’attrito vale quanto un bilancio.
Rimettiamo ordine nel metodo per leggere qualsiasi dossier. (1) Attori: chi c’è e cosa vuole. (2) Spazio: su quali territori e infrastrutture si gioca. (3) Tempo: orizzonte breve, medio, lungo. (4) Strumenti: diplomazia, tariffe, sanzioni, norme, propaganda. (5) Canali verso i mercati: energia, commercio, fiducia. Rispondere a queste domande non predice il futuro, ma limita l’errore e separa rumore e segnale.
Facciamo un esempio completo “da tavolo di cucina”: una crisi in uno stretto strategico. Le compagnie deviano rotte, i noli aumentano, le assicurazioni rialzano i premi, gli arrivi di grano e fertilizzanti rallentano; l’energia “via mare” pesa di più; gli Stati rilasciano scorte o tagliano accise; le banche centrali misurano l’impatto su inflazione e tassi. In borsa salgono shipping e assicurazioni, soffrono gli energivori, si muovono le valute dei Paesi esportatori. Non è magia: è catena causale leggibile.
Un’ultima bussola sui limiti: la geopolitica non è un segnale di trading. È una cornice per capire perché certi prezzi diventano sensibili. Il lavoro di chi investe—e di chi consiglia—è tradurre la cornice in scelte sobrie: diversificazione ampia, orizzonte coerente, niente scommesse su un solo evento. La prudenza fa meno rumore, ma tiene a galla i portafogli.